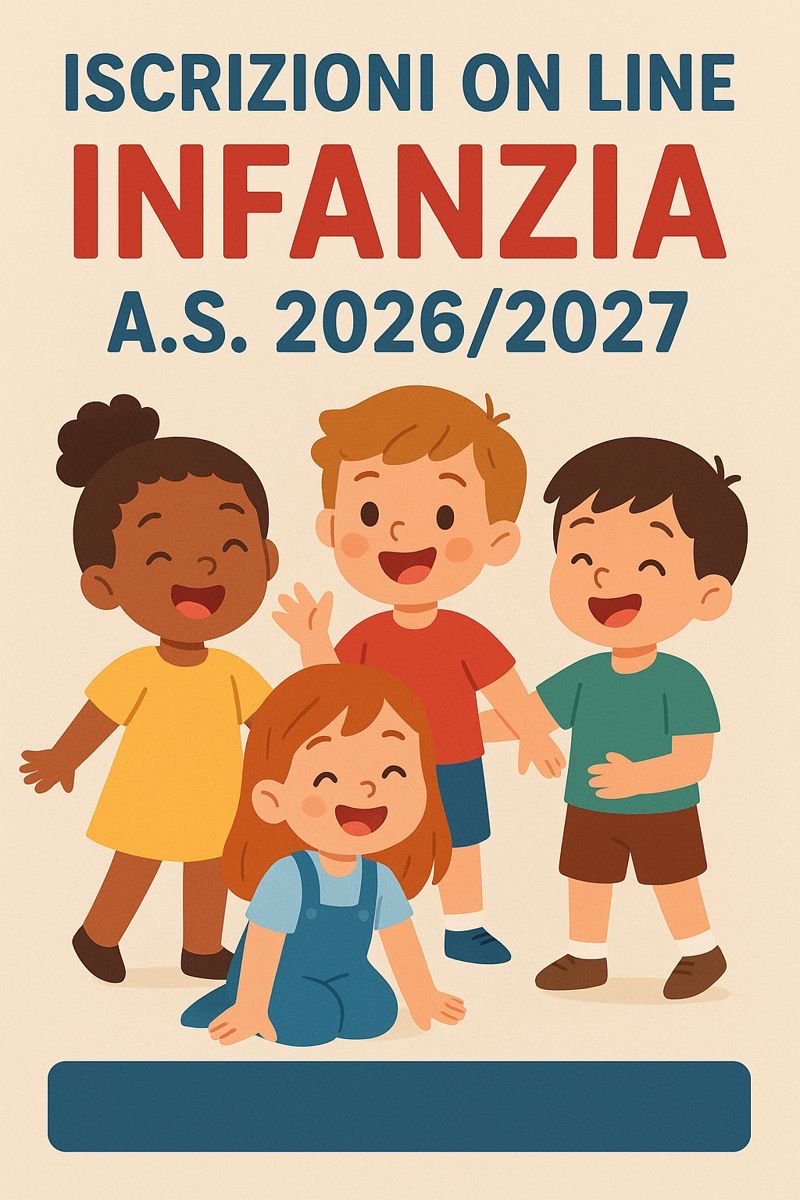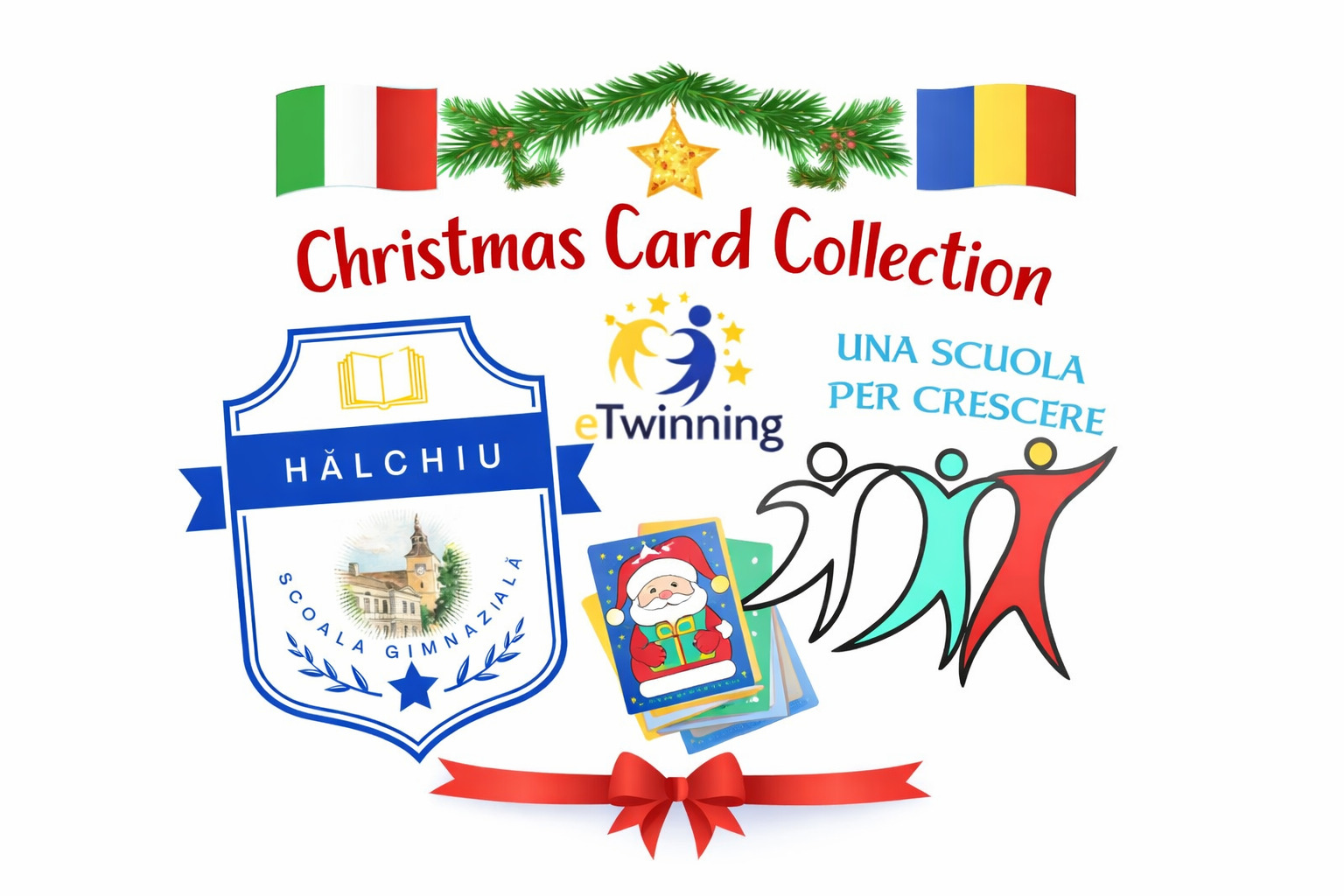Presentazione
Le Linee guida 2014 aggiornano e ampliano quelle del 2006, riconoscendo che la presenza degli alunni con cittadinanza non italiana è ormai una dimensione strutturale della scuola italiana.
Non si parla più solo di “integrazione”, ma di educazione interculturale, intesa come prospettiva comune che coinvolge tutti. Tutti i minori presenti sul territorio italiano hanno diritto all’istruzione, indipendentemente dalla cittadinanza o dalla regolarità del soggiorno (art. 45 D.P.R. 394/1999).
La scuola è luogo di incontro e di appartenenza, dove ciascun bambino e ragazzo trova riconoscimento, sicurezza e possibilità di crescita.
L’accoglienza
Si evidenzia che la presenza di alunni stranieri nel sistema scolastico italiano è oggi strutturale, e comprende diverse tipologie: nati in Italia da genitori stranieri, neo-arrivati, alunni con ambiente familiare non italofono, minori non accompagnati, figli di coppie miste, alunni adottati di origine straniera, alunni delle comunità Rom/Sinti/Caminanti. Ogni tipologia presenta bisogni specifici: ad esempio un alunno neo-arrivato può incontrare difficoltà linguistiche molto rilevanti, mentre un alunno nato in Italia da genitori stranieri potrebbe avere padronanza dell’italiano ma altre forme di svantaggio invisibili.
Ogni istituto deve predisporre procedure chiare per accogliere gli alunni stranieri, curando:
- l’iscrizione, anche in assenza di documenti di soggiorno;
- la raccolta di informazioni sulla storia scolastica e familiare;
- il colloquio con la famiglia, con eventuale mediazione linguistica;
- l’assegnazione alla classe in base all’età anagrafica, salvo motivate eccezioni;
- il primo inserimento nella comunità scolastica attraverso attività relazionali e di conoscenza reciproca.
L’accoglienza è un processo che coinvolge tutti: dirigente, docenti, personale ATA, compagni e famiglie. La lingua è la chiave dell’inclusione.
Le Linee guida distinguono due percorsi:
- Italiano per comunicare (livello di sopravvivenza, linguaggio quotidiano, interazioni di base);
- Italiano per studiare (linguaggio disciplinare, astratto, lessico tecnico).
Si raccomanda di attivare laboratori di italiano L2, piani personalizzati di apprendimento linguistico, materiali semplificati e strumenti compensativi. La lingua d’origine deve essere valorizzata come risorsa cognitiva e identitaria, non rimossa.
La didattica interculturale
L’intercultura non è una materia, ma un modo di fare scuola.
Significa riconoscere la pluralità dei punti di vista, costruire relazioni di dialogo, valorizzare le differenze come risorsa per tutti. Ogni attività — lettura, arte, scienze, cittadinanza — può diventare occasione di apertura e confronto. La scuola deve diventare una comunità che apprende insieme.
La valutazione e la relazione con le famiglie
Gli alunni stranieri sono valutati secondo i medesimi criteri degli altri, ma tenendo conto del percorso individuale, del livello di conoscenza della lingua italiana e del tempo di permanenza nel sistema scolastico.
Nelle prime fasi dell’inserimento, è opportuno privilegiare una valutazione formativa, centrata sui progressi e non sui limiti.
Il rapporto scuola-famiglia è un punto chiave dell’integrazione. È necessario:
- curare la comunicazione (documenti e avvisi tradotti, linguaggio semplice);
- favorire la partecipazione dei genitori alla vita scolastica;
- utilizzare mediatori linguistico-culturali quando serve.
Il dialogo con la famiglia sostiene la fiducia e rafforza l’alleanza educativa.
Le Linee guida chiedono alla scuola di passare da una logica dell’accoglienza emergenziale a una cultura dell’inclusione permanente, dove ogni alunno è risorsa e ogni lingua è una porta aperta.
L’obiettivo non è solo “integrare”, ma costruire una scuola capace di riconoscere e valorizzare tutte le differenze, rendendole parte della sua identità educativa.
Differenze operative tra scuola primaria e scuola secondaria di primo grado
|
Ambito |
Scuola Primaria |
Scuola Secondaria di Primo Grado |
|
Finalità educativa prevalente |
Favorire l’inserimento affettivo e linguistico del bambino. L’obiettivo è la fiducia: sentirsi accolto, riconosciuto, parte del gruppo-classe. |
Accompagnare l’alunno nella costruzione dell’identità e dell’autonomia, rafforzando competenze linguistiche e cognitive per lo studio e l’orientamento. |
|
Accoglienza |
Centralità della relazione emotiva. Il primo incontro è accompagnato da gesti di cura, gioco, racconti, attività di conoscenza reciproca. La scuola è la prima “casa” del nuovo Paese. |
L’accoglienza è più orientata all’ascolto e alla conoscenza personale. Si cura la presentazione del percorso scolastico pregresso e si valuta il livello linguistico e disciplinare per un inserimento consapevole. |
|
Iscrizione e assegnazione alla classe |
Inserimento nella classe corrispondente all’età anagrafica, salvo motivate eccezioni. La priorità è garantire la socializzazione e la continuità del percorso. |
Inserimento nella classe corrispondente all’età, ma con valutazione più attenta delle competenze pregresse e dell’eventuale ritardo scolastico. Possibile flessibilità motivata in casi specifici. |
|
Apprendimento linguistico (Italiano L2) |
Si lavora sull’italiano per comunicare: vocabolario quotidiano, routine, gesti, canzoni, immagini. Il linguaggio nasce dal fare e dal giocare. |
Si lavora sull’italiano per studiare: lessico disciplinare, testi complessi, strutture sintattiche astratte. Si costruisce la lingua del pensiero e della conoscenza. |
|
Didattica |
Fortemente esperienziale, narrativa, cooperativa. Le attività si basano su routine, storie, lavori manuali e simbolici. Il gruppo è contenitore educativo. |
Più strutturata e metacognitiva. Si introducono strumenti di studio, mappe, glossari, e percorsi linguistici per disciplina. Si educa al metodo di lavoro. |
|
Materiali e strumenti |
Materiali visivi e multisensoriali: immagini, cartelloni, oggetti, schede semplificate, giochi linguistici. Uso di tutoraggio tra pari. |
Materiali semplificati e adattati per discipline. Uso di glossari bilingue, dizionari digitali, mappe concettuali, strumenti compensativi per lo studio. |
|
Valutazione |
Osservazione qualitativa e descrittiva. Si valorizzano i progressi linguistici e relazionali più che i livelli assoluti. |
Valutazione coerente con il percorso individuale ma ancorata ai criteri comuni. Si distinguono difficoltà linguistiche da difficoltà cognitive. |
|
Relazione scuola–famiglia |
Forte accompagnamento relazionale: incontri con mediatori, comunicazioni semplificate, partecipazione ai momenti di vita scolastica. |
Comunicazione orientativa e informativa: spiegare il sistema scolastico, i criteri di valutazione, le scelte future. Attenzione alla comprensione linguistica dei genitori. |
|
Orientamento |
Si introduce gradualmente il concetto di “mestiere del sapere”: conoscere le proprie capacità e passioni. |
Centrale: aiutare gli alunni e le famiglie a scegliere consapevolmente il percorso successivo, evitando discriminazioni basate sulla lingua o sull’origine. |
|
Intercultura |
Esperienza vissuta: fiabe dal mondo, feste, cibi, colori, parole. L’intercultura è gioco e scoperta. |
Esperienza riflessiva: confronto tra culture, diritti, cittadinanza, stereotipi. L’intercultura è pensiero critico. |
|
Formazione dei docenti |
Focus su strumenti relazionali e strategie di comunicazione. |
Focus su didattica L2 disciplinare, valutazione equa e percorsi di orientamento. |
|
Obiettivo simbolico |
Accogliere un bambino significa offrirgli un linguaggio per sentirsi a casa. |
Accompagnare un ragazzo significa offrirgli parole per scegliere il proprio futuro. |
Il Protocollo di Accoglienza e Integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Arpino” definisce criteri e procedure condivise per l’accoglienza e l’inclusione degli alunni con cittadinanza non italiana, promuovendo una scuola aperta, solidale e interculturale.
Fasi operative - estratto dal Protocollo d’Istituto
- Iscrizione e primo contatto
la segreteria accoglie la domanda in qualsiasi momento dell’anno, anche in assenza di documenti, raccoglie i dati anagrafici, acquisisce la scelta sull’insegnamento della Religione Cattolica e scolastici e informa la Commissione Accoglienza, che organizza un colloquio con la famiglia.
- Assegnazione alla classe
Nella scelta della classe rimane fondamentale, come risulta dal DPR n. 394 del 31.8.1999, art. 45, il criterio generale della corrispondenza tra la classe e l’età anagrafica, salvo che il Collegio non deliberi l’iscrizione ad una classe diversa sulla base di:
- ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno che può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica;
- accertamento di competenze, abilità e livello di preparazione dell’alunno;
- del titolo di studi eventualmente posseduto dall’alunno.
La scelta della sezione avverrà sulla base dei seguenti criteri:
- il numero di alunni per classe;
- la presenza di altri stranieri: si cercherà di evitare di concentrare un numero eccessivo (la C.M. n.2/2010 prevede il limite massimo del 30%) di alunni stranieri in un’unica classe al fine di garantire una migliore integrazione ed uno sviluppo positivo del processo di apprendimento per tutti;
- la presenza di altre situazioni problematiche (alunni diversamente abili, DSA, BES…)
- Inserimento e osservazioni
L’inserimento dell’alunno con cittadinanza non italiana è un processo collegiale e condiviso, che coinvolge tutti i docenti della classe. Il Consiglio di classe o il team docente cura l’adattamento della didattica e dei materiali, promuove la partecipazione attiva dell’alunno attraverso attività cooperative e strategie di facilitazione linguistica, e mantiene un dialogo costante e costruttivo con la famiglia.
Entro 30 giorni dall’ingresso dell’alunno, il Consiglio di classe (o il team docente) elabora un progetto di accoglienza e un Piano Didattico Personalizzato (PDP), anche in forma temporanea, che documenti le misure linguistiche e metodologiche adottate. Il documento, sottoscritto dal coordinatore di classe, viene trasmesso via e-mail all’indirizzo istituzionale cnic817008@istruzione.it .
Si precisa che nella prima fase dell’inserimento scolastico, l’insegnamento della lingua italiana come L2 deve tendere soprattutto a:
1. fornire allo studente straniero gli strumenti linguistici che gli possono permettere di partecipare ad alcune attività comuni della classe;
2. sviluppare l’italiano utile sia alla scolarizzazione sia alla socializzazione in generale.
L'alunno impara a comunicare con compagni e docenti, apprende il lessico e i modi per la conversazione (richiamare l’attenzione, chiedere, denominare oggetti, azioni, rispondere a richieste e a comandi, esprimere i propri vissuti…). La lingua presentata è legata al contesto, ai campi di attività comunicativa del quotidiano. I tempi proposti tengono conto degli interessi e dei bisogni dell’alunno straniero affinché trovi nella scuola un ambiente sereno nel quale stare bene. Inizialmente ci si può avvalere di strumenti di facilitazione linguistica come: cartelloni, alfabetieri, cartine geografiche, testi semplici o semplificati, strumenti audiovisivi o multimediali, ecc. Tali strumenti aiutano l’alunno a sviluppare la conoscenza della lingua per comunicare. Una volta superata la fase iniziale si può iniziare ad avvicinare l’alunno alla conoscenza della lingua italiana specifica necessaria per comprendere ed esprimere e rielaborare i contenuti delle varie discipline.
La scuola non si limita ad accogliere, ma costruisce appartenenza. Ogni lingua è una porta che si apre, ogni bambino un ponte tra culture. L’I.C. “Giovanni Arpino” rinnova il proprio impegno a essere una comunità educativa